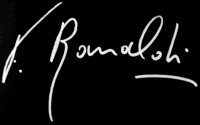- Annuario d’Arte Contemporanea Artisti contemporanei, ACCA in…Editrice S.r.l, Roma (Edizioni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011).
- Boè, Anno III, n.2, marzo-aprile 2006, Centro Diffusione Arte, Palermo.
- Avanguardie Artistiche, Artisti Contemporanei, Centro Diffusione Arte Editore, Palermo. (Edizioni 2006 e 2007).
- C.A.I. Censimento Artistico Italiano 2010, Centro Diffusione Arte Editore, 2010 Palermo.
“…Il pennello di Ranaldi scava nel colore e contorce, suscitando toni rivelatori dell’animo, come nelle foglie secche sparse sul tavolo, nelle foglie di granturco, nel giornale sgualcito e nel nodoso gambo del girasole. Ma quel lavoro di scavo è ancora più evidente nello scoglio che affiora da un mare calabro, intenso di miti e di dei. Quel pennello che contorce è ancora evidente nell’albero immenso su un paesaggio boscoso e collinoso, davanti ad un cielo crepuscolare che attende i fauni e le ninfe. Questo è il canone classico del pittore che corre in cerca del perfetto equilibrio, che è schivo alle tendenze o alle concettose e astruse frasi, capaci oggi di reggere fumose ed effimere mode…”.
Franco Pompili; Note su una personale, 1984
“…La natura costituisce un’attrazione potente sull’ispirazione artistica di Franco Ranaldi, una natura osservata come fenomeno che ispira energia e bellezza, che rivela a volte una potenza anche inquietante… affascina questo rendere la natura come presenza viva quasi parlante pur carica del suo mistero che nasconde negli sfolgoranti colori, densi e pieni, nel suo stagliarsi netta nella pienezza di turgidi volumi. Nella figura umana c’è un venir meno di questa tensione sia nelle figure di uomini che, in maggior misura, in quelle femminili più dolci e sfumate forse perché colte in atteggiamenti intimi e quotidiani. Si avverte certamente la lezioni di grandi maestri…ma reinterpretati con lo stile del tutto personale di Ranaldi”.
Emilia Forconi Occorsio; Note su Franco Ranaldi, 1997
“… Sorprende la sua capacità di scegliere i temi, di sfumare il racconto con sintetica semplicità, di fermare l’immagine al momento giusto con la sapienza della citazione colta o con l’abbandono nostalgico ai sentimenti, o con la sottile ironia che lo distingue e lo perseguita da vero filosofo… La sua capacità di analisi lo spinge più ad approfondire che a sperimentare, così tutta la sua produzione grafica e pittorica diventa una disincantata meditazione sulla realtà e le sue illusioni espressa con lirica compostezza, evitando gli scatti iperbolici o le fratture di stile. Ovunque ti circonda una natura forte e vibrante, capace di concentrarsi nelle esuberanti contorsioni degli ulivi. Di abbandonarsi alle delicate carezze del vento che scompiglia e sottomette teneri fiori di campo, fragili interpreti di un totale respiro della terra. Di dilatarsi in quelle fresche aperture di mare increspato pronte a sopportare l’inquieta intrusione di scogli quasi surreali: inconsce concrezioni che ci sbarrano l’orizzonte e ci danno l’esatta misura di quanto poco l’uomo possa abbandonarsi in una natura felice. In questo si compiace di amare de Chirico, ma ritrova l’oggettività di Caravaggio e persino l’immediatezza visiva dei macchiaioli. Siamo foglie accartocciate, frutti violati dal tempo, meloni infranti che giacciono su prospettici tappeti erbosi… Somigliamo ad alberi soli, ritti e fieri come condottieri rinascimentali, tracce storiche di paesaggi lontani, aperti e digradanti…”.
Caterina Capalbo; Note critiche su Franco Ranaldi, 1994
“… Franco Ranaldi intreccia con la natura un rapporto d’amorosa passione, varcando in punta di piedi il regno del mistero assoluto e quindi dell’impermanenza. Vita e morte si susseguono incessanti con il ritmo di un respiro e la grazia di un battito d’ali. Se la mano dell’artista è felice, ma trepidante, al cospetto della tela bianca, così lo è la sua anima quando raggiunge, con la complicità dell’arte, sempre maggiore intimità con tutto ciò che dal Divino è creato…”.
Sandra Monteleoni; Note su una mostra di Ranaldi, 2005
Qui, in questa natura veduta dal basso, senza filtri, con lo stupore panico dell’infanzia, tutto è possibile: anche che i fiori e gli umili steli d’erba finiscano quasi con il torreggiare come alberi, che i girasoli diventino una schiera compatta di sentinelle, a scrutarci con un che di minaccioso a difesa del prato di lavanda, che gli ulivi assumano connotati antropomorfici, inquietanti, emergendo d’improvviso da uno squarcio di nebbia mattutina. Ci sovviene la stupita fanciullezza di Montale, in cui rapido rispondeva a ogni moto dell'anima un consenso esterno.
Poi il risveglio: lo stupore dell’infanzia cede il passo a una presa di coscienza che ha un che di malinconico e doloroso, anche quando nella pittura di Ranaldi si scherma dietro vedute serene, aperte, solatie, con un punto di vista rialzato, al di sopra di ampi piani orizzontali. Il risveglio è una presa di coscienza che nella poetica dell’artista rivela una matrice autenticamente umanistico- rinascimentale: quella relativa alla questione del ruolo dell’individuo nello spazio e nel tempo, in un cosmo governato da una natura orgogliosa, autoreferenziale, retta dalle sue proprie leggi. Le immagini del risveglio sono filtrate dalle lenti della consapevolezza e dell’esperienza, della coscienza e della conoscenza storica ma anche della nostalgia di ciò che è stato o di ciò che non potrà mai essere: ecco allora un’immagine di armonia classica, panteistica, di un mondo che non c’è più e che ci è consentito di afferrare solo per un attimo, nella contemplazione della perfezione e della smaltata lucentezza di un vaso greco, mentre una luce arcana, abbacinante, si riflette in primo piano sulle superfici della natura morta abbandonata sull’erba: un attimo dopo quella luce irreale si spegnerà per sempre e il vaso greco, in frantumi, verrà trascinato via dalla corrente del tempo riemergendo come un reperto fossile sulla riva del mare.
Le immagini della consapevolezza sono nitide, i volumi netti, la luce ferma: alcuni libri chiusi, forse diari di una vita passata, delle foglie morte, un tubetto di colore inutilmente aperto, giacciono su un tavolo che ha il biancore di una lastra tombale; ma la melagrana, che con il suo volume sferico domina la composizione, è simbolo rinascimentale di resurrezione. O, più semplicemente, sta a ricordarci il potere rigenerativo della natura, la sua vittoria sul tempo umano: ecco allora che gli strumenti della conoscenza e della creazione artistica diventano dei reperti di un tempo finito e concluso, come reperti sono i frammenti dei vasi greci o i muri scrostati di un antico podere, con il torrente d’erba che tracima per ogni dove, pronto a divorarli.
Resta l’anelito ad immergersi nel flusso del tempo della natura, dei suoi ritmi solenni ed eterni: solo per pochi istanti ci è permesso di carpirne i meccanismi segreti, come quelli che legano al paesaggio, in un muto colloquio esclusivo e privilegiato, i gesti ancestrali, reiterati da millenni, della coppia di contadini che caricano con la soma il loro asinello, davanti a un casolare. Lontani, nello spazio e nel tempo, con la solennità metafisica del loro contegno, la donna, l’uomo e l’animale sembrano prendere parte ad un sacro rito che vede coinvolti loro, la natura e nient’altro: a noi è concesso solo spiarli da lontano, senza contaminarne la sacralità arcana.
Sono presenze reali o una proiezione della nostra immaginazione, assetata di armonie?
Il finito e l’incommensurabile costituiscono i due poli di attrazione della pittura di Franco Ranaldi, la dialettica di due elementi che alcune istantanee, folgoranti epifanie conciliano attraverso la rivelazione dell’infinito e del suo mistero nell’apparenza delle cose.”
Pier Paolo Racioppi; Franco Ranaldi, Dipinti (2003-2006), Roma, 2006.
Dipingere è un atto di fede e l’artista è il profeta che scuote la nostra pigrizia visiva così Franco Ranaldi ci coinvolge nel suo percorso figurativo. Come dimenticare la pregnanza, la forza magnetica delle sue opere? Come scordare la struttura dei suoi disegni? Come sfuggire al richiamo dei suoi paesaggi? Al pari di uno scultore, che non sbaglia il colpo di gradina sulla pietra e agisce e modella fino a piegare al suo volere la materia, così lui scolpisce il colore calibrandone il timbro, il tono, lo spessore. Moltiplicandone la stesura nella trama sottile delle pennellate. Un lavoro che indubbiamente richiede pazienza e fiducia nell’osservazione.
E, oltre al visibile richiamo oggettivo delle opere, cosa trapela della personalità di un artista, della sua vita, del suo pensiero? Per Ranaldi è la salda corrispondenza tra l’interiorità e l’agire. Tra l’essere persona limpida, schietta, saggia, ponderata ma tenace e la ricerca di una poesia del quotidiano, consolatrice ma enigmatica con lo stupore di non poterla abbandonare tanto essa è ricca e profonda.
Se l’arte presuppone delle scelte, che siano legate all’artista o al contesto, ai luoghi e ai tempi entro cui si muove e prende vita l’opera stessa, Franco Ranaldi ha fatto la sua scelta: osservare la “bellezza minacciata” per dirla con le sue parole di poeta. Di conseguenza si è sentito controcorrente: un figurativo per vocazione e senza rimpianti che nei suoi studi non ha trascurato l’astrattismo ma lo ha travalicato per la necessità congenita di vedere la natura, capirne il linguaggio e ascoltarne il battito vitale. Questa fu materia di identica predilezione per tanti grandi artisti. Maestri di metodo e di pensiero che rivendicano una paternità almeno ideologica nella sua arte che, nella produzione grafica e in quella pittorica, esprime il segno del debito nei loro confronti.
Cézanne, quello delle nature morte e dei paesaggi; De Chirico negli stessi temi resi più opulenti e fluidi dalla forza del colore; Guttuso per il compiacersi di una vivacità cromatica rovente di passione nell’incarnare le terre del sud; gli impressionisti e i macchiaioli per il gusto del taglio fotografico e del soggetto semplice ma godibile; Renoir per la stesura filamentosa del colore e per la serenità percettiva; Severini per la chiarezza inventiva dei recenti scorci parigini. Persino Magritte, inconsciamente latente, per quegli elementi che vivono quasi in sospensione magica.
Questa varietà di stimoli e di similitudini, assorbita al suo stile come fosse un dna irrinunciabile, si coagula in una ricerca personale dove le coordinate imprescindibili sono reverenziali: Caravaggio per l’innata volontà di osservare il dato sensibile nelle pieghe più umili e meno scontate (visibile con una tavolozza cromatica più scura e terrosa in certa sua produzione spesso negata al pubblico per il pudore di un confronto impossibile) e Dürer per la volontà di incidere e tormentare le forme grafiche. Entrambi sono la fonte inesauribile delle sue meditazioni artistiche.
Attratto nell’orbita di una costellazione artistica di prestigio che lo indirizza, lo sostiene, lo guida ma non lo intimorisce tanto lui è incardinato in se stesso e nel suo agire, la sua ricerca non è mai univoca e si rivela diversa in relazione ai soggetti e alle tecniche. Ci appare dialetticamente più tormentato, volitivo, inquieto e incisivo nella grafica e nei disegni dove il soggetto si solidifica energico e irrompe oltre il campo operativo del quadro. Poi equilibrato, sciolto, libero e musicalmente accordato nelle tecniche miste, ad acquerello e china, dove il soggetto si adatta agilmente allo spazio e il sentimento è sereno, puro, appagato. Infine straripante di emozioni ma consapevole, esigente e metodico nell’acrilico e nella tecnica a olio, cardine del suo tormento e della sua passione.
Il suo vocabolario è accessibile e chiaro. Ma il lessico non è comune e assorbe il clima acerbo di una visione innocente in un fulgido giorno intaccato solo dalla fugacità del tempo. È ciò che resta di un Eden amato e vissuto di cui sentiamo ancora il palpito. Il mare, l’acqua del lago o del torrente, il cielo gravido di nuvole, le spiagge, un casolare, il rudere, uno scorcio cittadino, un paese arroccato, i campi ammantati d’erba e di fiori, li abbiamo già visti, siamo già stati in quei luoghi, c’è ancora la nostra presenza. L’impronta dei nostri passi sulla sabbia delle dune vi resta indelebile sebbene non appaia, così come abbiamo passato la nostra mano sui fiori, ne abbiamo sentito il profumo mentre ci siamo avventurati lungo i sentieri tracciati verso la collina. La potenzialità del ricordo convive con la nostra assenza e vorremmo rivivere quegli attimi, lontani dall’intromissione di un materialismo imperante, fuori dal circuito della logica ossessiva di una natura sottomessa all’uomo che adesso si rivela unica protagonista.
E se Ranaldi la osserva, lo fa da un punto privilegiato, da un’angolatura lontana capace di abbracciare una visuale estesa o da un punto ravvicinato in grado di scoprire come attraverso una lente ciò che l’occhio distratto non vede. Ciò che esiste e vive sotto il guscio stesso della natura, l’epidermide del creato. Ciò che si trascura solo perché non appartiene ai primi piani.
Colui che scruta la materia nelle sue pieghe nascoste vede in essa la pittura. In quest’indagine di particelle infinitesimali è il suo essere astratto. Allora i solchi della corteccia degli ulivi si fanno più incisivi e ne cogli la ferita profonda, l’abisso scuro, le forme antropomorfe, i nessi con l’inquietudine interiore. Gli steli dei fiori s’infittiscono, si moltiplicano imponendo uno sforzo visivo al riguardante, puoi contarli ad uno ad uno, distinguerli gli uni dagli altri, vederli innestati al terreno con la stessa forza delle radici degli alberi, sentire il vento che li scuote e li piega. I massi e i ciottoli di un torrente diventano sculture aggredite dal flusso incessante dell’acqua, vittime di una contesa senza speranza. Tutto appare godibile, esaltato dalla vivacità dei colori eppure è latente un rimpianto, una promessa non mantenuta. Nell’aria nitida incombe un’attesa.